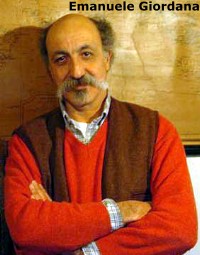Telegiornaliste anno V N. 12 e 13 (183 e 184)
del 30 marzo e 6 aprile 2009
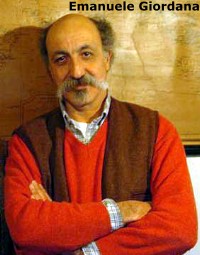 Emanuele
Giordana, la magia dell’Afghanistan
Emanuele
Giordana, la magia dell’Afghanistan
di Erica Savazzi
Afghanistan, Pakistan, Tibet. Viaggi e blog.
Radio e informazione. Lo sguardo sull’Asia
di
Emanuele Giordana.
Per prima cosa ben tornato in Italia.
«Sono a casa da tre settimane (quattro, al
momento della pubblicazione, ndr) ma
se potessi partirei domani, non importa per
quale destinazione».
Sei tornato dall'Afghanistan, Paese con cui hai una “storia” ultra
trentennale.
«Sono andato lì per la prima volta nel 74.
Gli afghani sono delle persone molto
particolari, sono una razza speciale, molto
affidabili, persone serie. Vivono in un
Paese disgraziato, non parliamo poi della
situazione delle donne. E poi l'Afghanistan
è un Paese che mi piace, ha una sorta di
magia che conquista».
Ti sei anche fatto operare di ernia, a Kabul.
«Era per evitare il servizio sanitario
italiano (ride, ndr). In realtà era
un ospedale sostenuto dalla Cooperazione
italiana per cui sapevo chi mi avrebbe
operato. Mi sembrava anche un gesto di
fiducia doveroso nei loro confronti».
La Farnesina ha invitato le Ong italiane a lasciare il Paese.
«Secondo me è stata una comunicazione con un
difetto di origine: sarebbe stato meglio
discuterne prima con le organizzazioni
presenti sul posto. Ovviamente se qualcuno
si sente invitato a fare le valigie reagisce
con forza: le Ong sono enti autonomi dal
governo, per cui si può consigliare una
certa azione, ma bisogna tener conto della
loro sensibilità».
Questa rottura è ricomponibile?
«Spero che si risolverà in un colloquio: le
Ong hanno chiesto di incontrare Frattini per
parlare della presenza della società civile
italiana in Afghanistan. Se restano solo i
soldati è difficile parlare di
ricostruzione».
Obama vuole cambiare strategia.
«Gli americani hanno una posizione che
inizialmente è sembrata essere solo una
scelta di carattere militare, cioè inviare
17.000 soldati, ma in realtà la cosa è più
complessa. Prima di tutto sono solo 17.000 e
non 30.000 come i comandi militari avevano
chiesto, e in secondo luogo, questo ha anche
a che vedere con il ritiro dall'Iraq. In
realtà l'amministrazione americana sta
ripensando tutta la strategia in
Afghanistan, dando maggior forza ai capi
tribali, agli organismi di governo
decentrato e con un rafforzamento
dell'esercito nazionale che gli americani
vorrebbero portare a 400.000 uomini, una
cifra importante che sottintende in un certo
senso il nostro disimpegno. Gli americani
sembrano voler cambiare strategia puntando
anche su un aumento dei funzionari civili,
quindi all'ambasciata, nella cooperazione e
tra i consiglieri del governo. Inoltre
stanno spingendo sul negoziato con i
talebani. Una inversione molto interessante
che potrebbe influenzare anche gli europei».
Non è un pericolo trattare con i talebani?
«È pericoloso ma inevitabile. La guerra è
arrivata a un punto morto: noi non possiamo
vincere, e nemmeno i talebani, per cui non
rimane che il negoziato. Adesso possiamo
negoziare da una posizione di forza, cioè
con una presenza militare, ottenendo dei
risultati che non ci sarebbero se col tempo
e il logoramento della guerra - in termini
di uomini e denaro - le truppe occidentali
si dovessero ritirare abbandonando il Paese
a una nuova guerra civile che va evitata in
tutti i modi, anche negoziando col nemico».
Perché il tuo blog si chiama
Great game?
«Il Grande gioco è il nome che un
funzionario britannico diede al gioco
militare e diplomatico che tra la fine del
'800 e l'inizio del ‘900 facevano i russi e
gli inglesi nell'area dell'Afghanistan e del
Pakistan: gli inglesi per tenere la
frontiera dell'India e i russi perché
pensavano di invaderla. La parola poi è
stata ripresa da Kipling nel suo libro Kim,
in cui il protagonista diventa un agente del
Grande gioco al servizio di sua maestà
britannica. Ricorda il grande gioco fatto
sulle spalle dell'Afghanistan che non è mai
finito».
Le vicende Pakistane hanno influenza in Afghanistan?
«Pakistan e Afghanistan si influenzano
reciprocamente, ecco perché bisogna correre
ai ripari e cercare il negoziato su tutti i
fronti. In Pakistan purtroppo le cose si
sono molto deteriorate per cui oggi è la
situazione forse più pericolosa dal punto di
vista di diritti delle donne o
dell'amministrazione della giustizia. È
ancora più pericoloso perché si tratta di
uno stato definito - come invece non è
l'Afghanistan – il cui governo è molto
instabile e debole».
Da dove deriva la situazione pakistana?
«Credo derivi in buona parte da una cattiva
gestione delle aree dove si svolge il
conflitto, che sono state neglette da parte
dello stato centrale. Sono state lasciate in
una situazione quasi di autogoverno, che in
un certo momento è diventato desiderio di
separazione e di secessione. Questo
desiderio tende facilmente ad accoppiarsi
con ideologie estremiste, che si tratti
dell'islam o di altre teorie poco importa.
Bisognerebbe andare alla radice di quei
mali, proporre un intervento forte di
carattere politico ed economico in modo da
sottrarre agli islamisti quella massa di
disoccupati, disillusi, disperati che
aderiscono a una ideologia forse più per
necessità che per convinzione».
Lavori anche in radio.
«Oramai sono sette anni che ho un contratto
stagionale – sono felice di essere un uomo
libero - a Radio3mondo, una
trasmissione che mi piace moltissimo e di
cui sono molto fiero. È un lavoro che faccio
molto volentieri. Parliamo solo di ciò che
accade fuori dall'Italia, credo che siamo
l'unica trasmissione che lo fa».
Qual è il livello dell'informazione sugli
esteri secondo te?
«Non ce n'è, oppure c'è in maniera superficiale
e a spot, e sempre di più occupandosi
dell'aspetto di costume senza guardare in
profondità. Questo non è colpa dei
giornalisti – in Italia ci sono tantissimi
bravi giornalisti – ma in parte di una
tradizione del nostro Paese di essere
ripiegato su se stesso e in parte
dell'editoria, che nonostante si sia aperta
un po' di più sul mondo, tende sempre a
presentare tutto in termini televisivi. Per
questo una trasmissione come
Radio3mondo secondo me è un piccolo gioiello
da salvaguardare».
Hai curato un insieme di
saggi sul Tibet, all’interno del quale hai
scritto un articolo su come la legislazione
internazionale ha affrontato il problema
della regione.
«Mi sono rifatto a una sorta di processo sul
Tibet che è stato istituito dal tribunale
Russell, un tribunale della società civile.
Alla fine si dimostra che il grado di
indipendenza del Tibet dalla Cina è una
realtà storica, di conseguenza, in base al
principio dell'autodeterminazione dei
popoli, i tibetani avrebbero diritto di
esprimersi rispetto al far parte della Cina
o meno. In sostanza la legislazione
internazionale mette il Dalai Lama - che non
chiede la secessione ma una larga autonomia
- in una posizione legalmente forte, mentre
la posizione dei cinesi è molto più debole
perché di fatto sono invasori».
Si puntava molto sulla pressione
internazionale.
«La pressione che viene dal basso, le
manifestazioni in Tibet, India, Nepal e poi
in Italia, Francia, Stati Uniti, non possono
durare all'infinito. Possono dare un
segnale, poi tocca alla politica coglierlo.
Questo non è stato fatto: in occasione delle
Olimpiadi anche i Paesi che erano più
filotibetani come la Francia o l'Italia -
che addirittura voleva ritirare la missione
sportiva - alla fine, grazie al fatto che la
Cina è una grande potenza economica, hanno
lasciato. Credo che i nostri leader siamo
colpevoli non meno dei cinesi di aver
abbandonato i tibetani».
Quale può essere allora una via di soluzione?
«Forse l'unica vera speranza è che all'interno
della società cinese - una società dinamica
dove ci sono degli intellettuali che hanno
chiesto di rivedere il modo in cui il
governo tratta la questione tibetana -
succeda qualche cosa. Forse oggi l'unica
speranza di combattere l'invasione della
Cina sono proprio i cinesi, però ovviamente
è una speranza a lunghissimo termine. E
senza la pressione internazionale sarà molto
difficile che la persone che vogliono
suggerire una posizione di apertura possano
veramente farlo».
Com’è che ti sei appassionato di Asia e
Medioriente?
«Ho viaggiato molto tra i 18 e i 25 anni, allora
era molto facile viaggiare a piedi, c'era la
guerra fredda e quindi poche guerre reali.
Di tutti i Paesi in cui ho viaggiato l'Asia
è quello che mi è rimasto nel cuore, e ho
continuato questa passione col lavoro. È
stata una grande fortuna fare allora quei
viaggi: a distanza di trent’anni tante cose
che allora non avevo capito o a cui non
avevo fatto caso un po' studiando e un po'
tornandoci con più consapevolezza sono
diventate un piccolo tesoro di esperienza e
cultura».
Immagino sia stato difficile partire.
«Era più semplice di adesso. C'era un movimento
giovanile molto aperto, e le famiglie forse
avevano meno timori o comunque non avevano i
mezzi per opporsi al nostro desiderio di
libertà. Alla fine il mondo era molto meno
pericoloso quindi era molto più facile
viaggiare, costava di meno e soprattutto non
avevamo allora la necessità di comodità, ci
accontentavamo di viaggiare su autobus
scalcinati. Credo soprattutto che fosse il
contesto storico di quel periodo: ora ci si
pensa due volte prima di intraprendere un
viaggio che in realtà poi si può fare lo
stesso, certo bisogna stare più attenti.
Partivamo e stavamo via magari quattro o sei
mesi, finché non finivamo i soldi. C'era più
libertà di movimento, che era una libertà
del sentimento. Non so se ci fosse più
coraggio, di certo c'era molta curiosità».